For the section ‘Books and Museums,’ we present the latest work by Francesco Erbani: a snapshot of the political management of cultural heritage.
by Network Museum
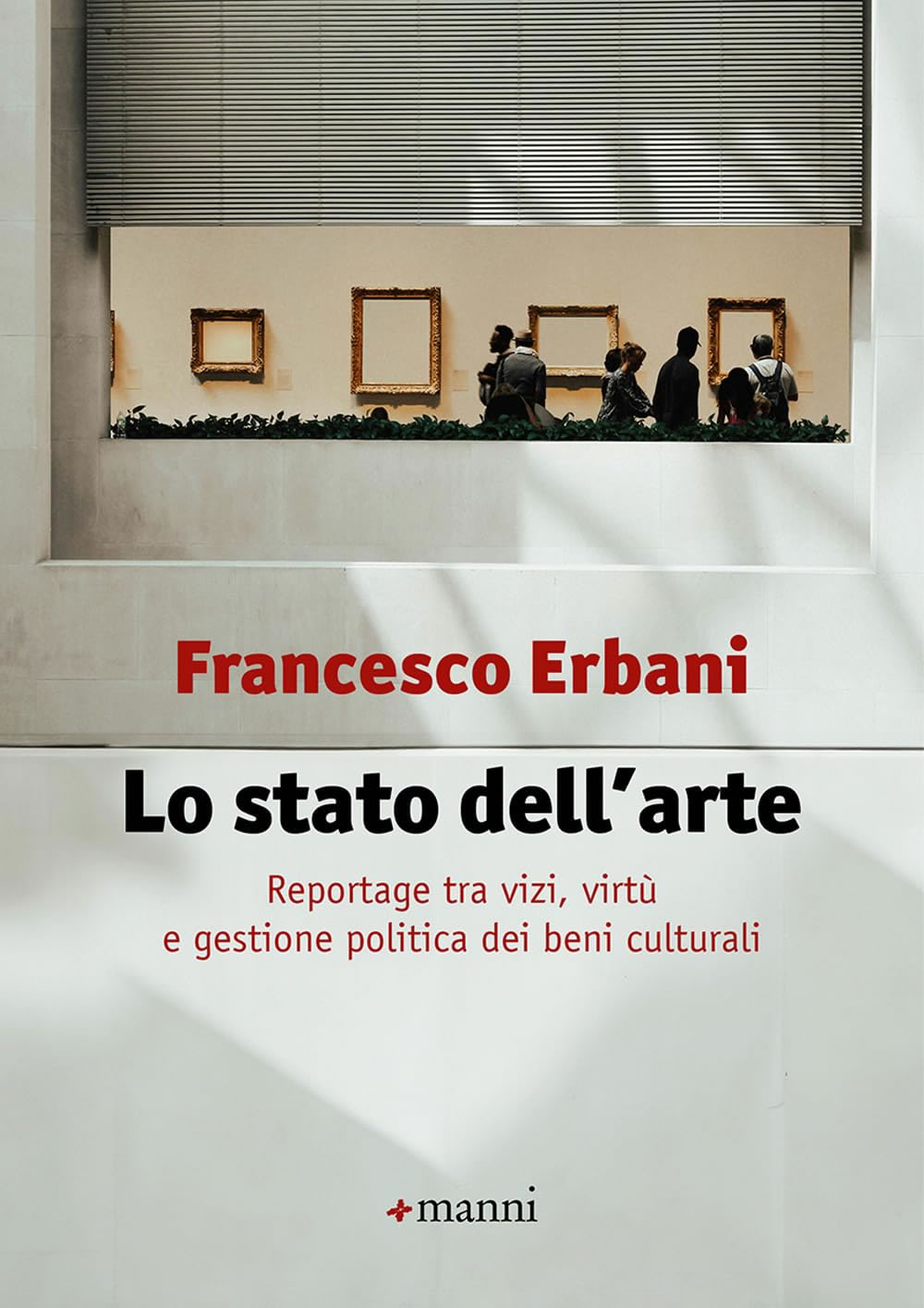
“Tanti fatti ‘llate nunn’ è sanno
però è meglio ca nuie cè spiegammo
o si no cu tutta a scienza ca’ tenimmo
jammo a mare cu tutt’ e panne!…”.
(Edoardo Bennato)
“Many facts others do not know,
but it is better for us to explain them, otherwise, with all the knowledge we have, we’ll sink with all our clothes on!…”
(Edoardo Bennato)
“Imagine a place where various people have agreed to meet. Some have studied a lot, others a little less, and others much more, though they professionally perceive themselves as inferior to those who have studied less. Others, much more gifted than all, cannot join the group because the group does not want them. The gathering convenes, and the members begin to express their desires and needs. Some criticize the demands of others, who, in turn, criticize the meeting place. Someone complains about the meeting’s timing; another prefers to take the train, while someone already has their car running (obviously double-parked). Some are mounted on very expensive bicycles. Everyone just criticizes, often without a specific reason. Each person speaks to suit themselves and those they consider their equals. Some flaunt their academic titles, others feel empowered by birth and connections, while others despair as life passes them by, unable to give it the meaning they desired. Someone raises their voice, someone winks, someone declares that everything needs to be redone, someone else says, ‘Those were the good old days.’ Others launch invectives at anyone who even considers discussing the things that make the world turn—things the group, so learned and credentialed, ignores in both meaning and use. Yet, no one asks where they should go, why, or for whose benefit.”
This sentiment emerged within the editorial team after studying the latest work by Francesco Erbani, titled ‘“Lo stato dell’arte“, published by Manni Editori. It is an essay that discusses museums, archives, archaeological areas, libraries, historic centers, and matters related to the superintendencies. It is a work that aims to take stock of the organization of the Italian cultural heritage system, describing events and institutional and political developments. It speaks of institutional rhetoric and the meager financial and human resources allocated to the sector. It questions the meaning of the concept of cultural heritage and what it can represent for a region, as well as the effort, in every sense, required to recover it, safeguard it, and ensure it for the community.
We feel compelled to share, at the beginning of this review, an excerpt from the preface of the book: ‘This book has the style of a journalistic investigation; it tries to narrate and interpret, selects, brings together facts, and attempts to analyze them with the help of various interlocutors. And therefore, it does not aspire to any hypocritical objectivity.’
We are, thus, dealing with an honest person, a journalist who does not succumb, at least based on the content, to the allure of protagonism. He openly admits to employing a political perspective, which, precisely by virtue of this acknowledgment, makes what is presented reliable, neither malicious nor malevolent, but rather a snapshot of a few decades of cultural heritage politics in Italy.
If, as happens in many photos, some individuals appear ‘blurred,’ restless, or even unsettling, know that it is not the photographer’s fault. Therefore, forgive the author for the human passion humbly admitted.
From the perspective of journalistic technique, being researchers devoted to the deepest Galilean fidelity, we are certainly not in a position to judge it. However, it seems evident to us the commitment and accuracy in the narration, precise and substantiated with careful descriptions of facts and circumstances, which, unfortunately, certainly do not bring honor to our cultural and museum system.
Let’s be clear, this is not a text on museology, and it is futile to search within it for anything other than an excellent exposition of facts concerning the evolution of cultural heritage administration policies in our country over recent decades. Those in our profession will find many things, unfortunately, all too familiar, and the reading might provoke fits of bile and nervous crises. However, we believe this could be a well-suited text deserving maximum visibility among those engaged in cultural matters.
The public—or, as is now fashionable to say, the audiences (it is telling that this linguistic shift has, in certain works, been hailed as a scientific breakthrough)—often has an idea of our system for managing cultural heritage that is far removed from reality. This perception oscillates between hearsay and feelings of absolute and unconditional faith in what a system, often self-referential, presents to its citizens.
We feel compelled to recommend ”Lo stato dell’arte” to anyone who wishes to “touch” with their own hands the costly clay feet of a giant, about which, incorrectly, everything and the opposite of everything is said. For many, culture could replace steelworks, a panacea for the economy and employment; for others, those who work in the cultural heritage sector live on air and sentiments and can, therefore, be underpaid, precarious, and deprived of the right to protest because culture is perceived as something owed: a pity that few have a clear idea of it, institutions included.
It is important that citizens become aware of inefficiencies, compromises, subterfuges, but above all, they must know that the king, whose successes and percentages we boast of, for whom we feel, alongside soccer, proud nationalists, is naked or, at best, not fully dressed. And, as we were told at school, he is capable and could do much more—for everyone.
We find it so strange that so many individuals, laden with academic titles, manage to complicate the nothingness done by others with yet more nothingness. We are like young idlers who, having inherited very expensive family assets, posture as the creators of such riches, while the purpose of such management should be entirely different.
Who said that an archaeologist knows how to manage communication or that a historian can analyze a budget, especially if there is no real understanding of culture and what a museum truly is? (Let’s be honest: there are museological definitions circulating that could organize a fair for the banal.) If a chief physician were, by some academic-divine cascade, an excellent organizer, we wouldn’t have problems managing hospitals.
It is not just a matter of staff shortages, an issue correctly highlighted in Erbani’s work, but also of knowing that a system—not merely a company—is a defined whole regulated by precise logics and requires many professionals capable of understanding and managing them, something our legal framework still ignores.
Even stranger is the fact that our system, apart from areas of restoration and conservation, fails to produce anything foundational to museological sciences, remaining deaf to terms such as didactics, neuroscience, organization, scientific research, purposes, objectives, experimentation, informatics, ergonomics, cognitive sciences, feedback measurement, creativity, and the relationship between public and private (considered as individual citizens, not just as businesses trading visibility for money).
As for lexicon, the picture—or rather, the snapshot—that emerges from ‘“Lo stato dell’arte” is so complex that even the narrative itself is affected, without attributing any blame to the author. It is the system itself that is so complicated as to be extremely difficult to narrate in a linear manner, despite the successful editorial result.
This is a text that should be adopted at the university level and used in museums to organize those quality circles that the ‘Kaizen’ of the 1980s advocated in Italy as grassroots participation in problem-solving. Unfortunately, at present, nothing can filter from the grassroots in the sector under consideration.
If we really want to point out a minor flaw in this excellent work, we would suggest that the author refrain from overusing or be very careful in employing lexical stereotypes such as: science, beauty, culture, company. Otherwise, we risk adding emptiness to emptiness: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (the pristine rose remains only in its name, we hold naked names).
© Copyright Infogestione
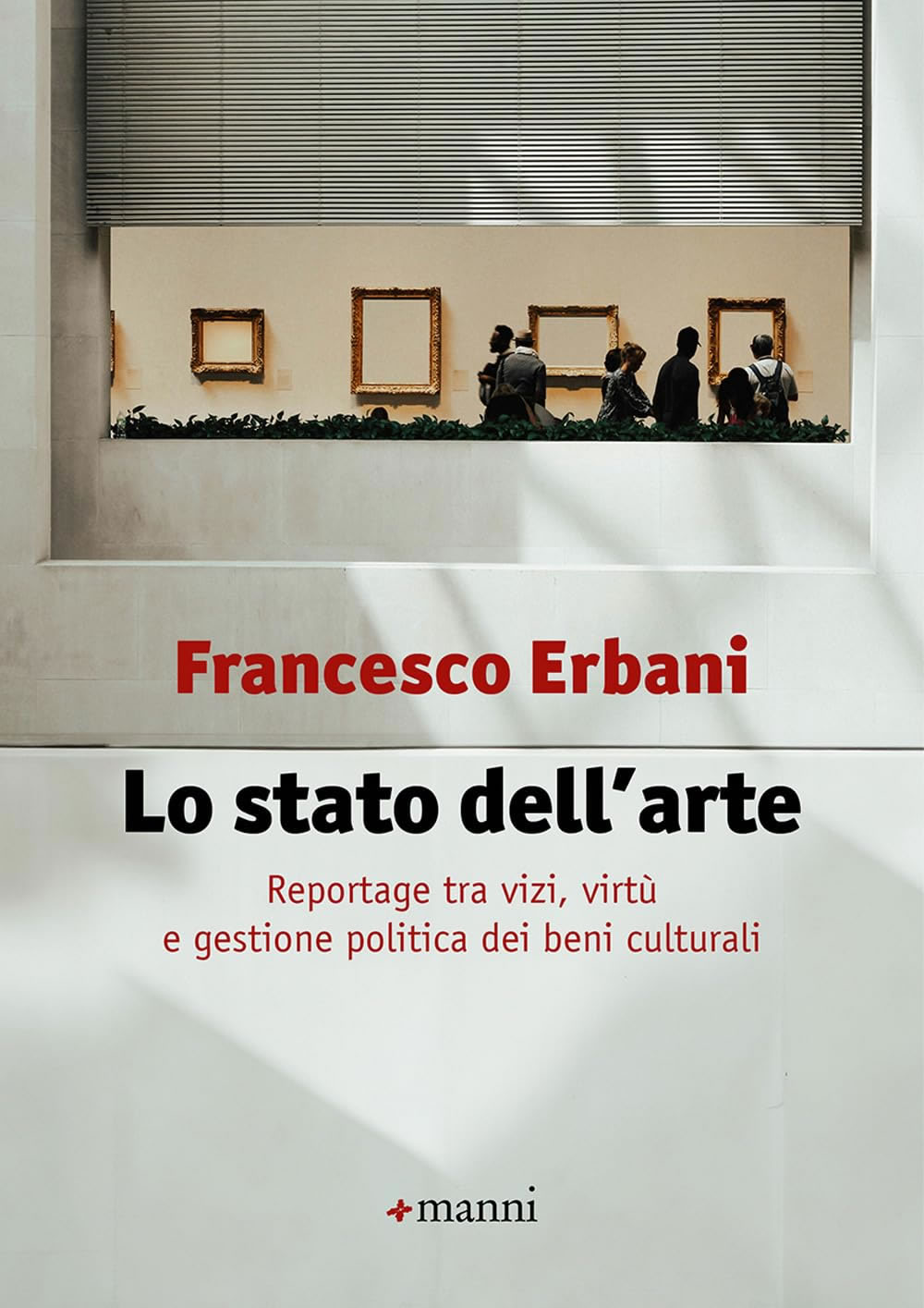
Versione italiana
Lo stato dell’arte
Per la sezione “Libri e musei” , presentiamo l’ultimo lavoro di Francesco Erbani : un’istantanea della gestione politica dei beni culturali.
a cura della redazione scientifica di Network Museum
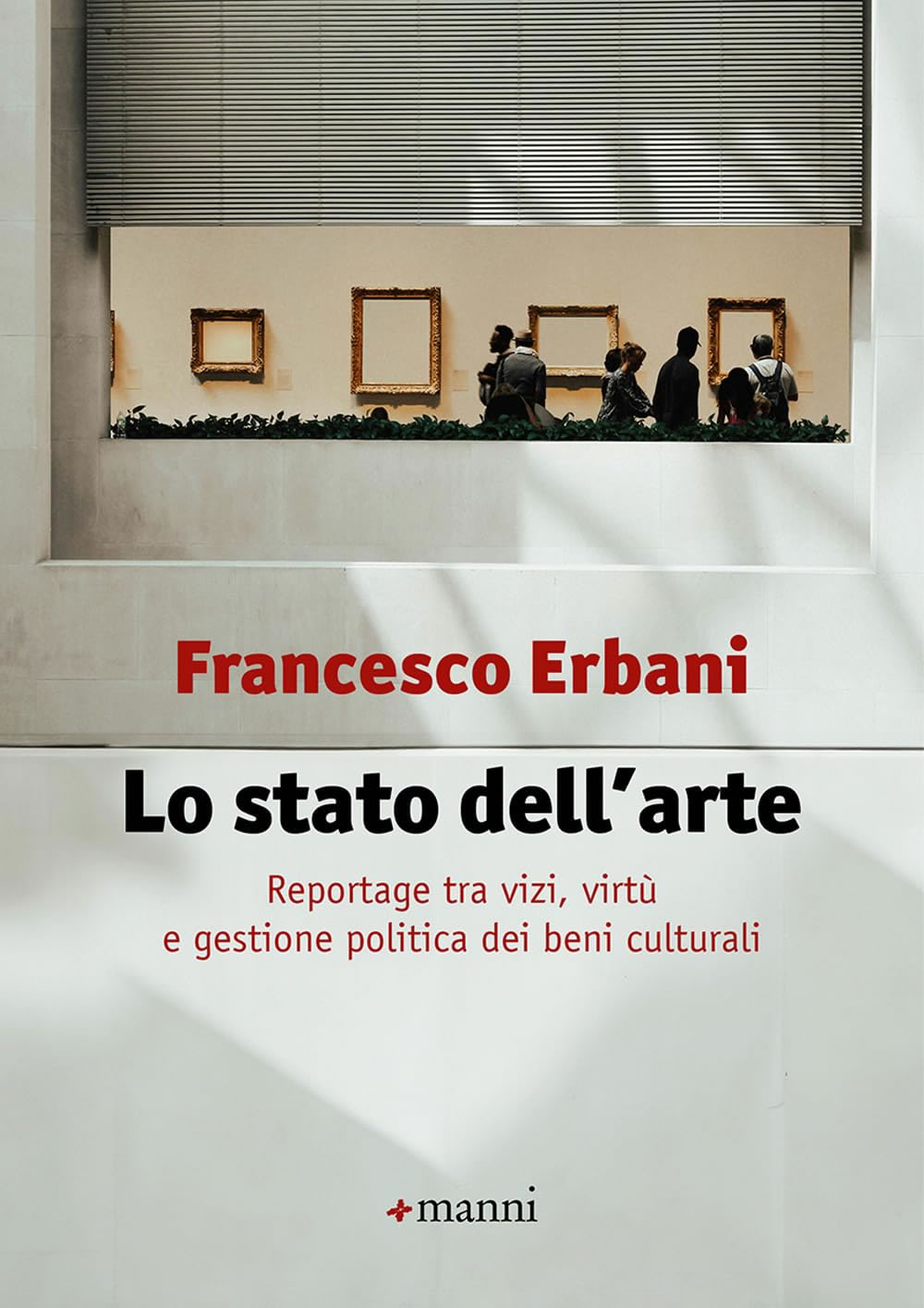
“Tanti fatti ‘llate nunn’ è sanno
però è meglio ca nuie cè spiegammo
o si no cu tutta a scienza ca’ tenimmo
jammo a mare cu tutt’ e panne!…”.
(Edoardo Bennato)
“Tanti fatti gli altri non li sanno,
però è meglio che noi li spieghiamo,
o altrimenti, con tutta la scienza che abbiamo, andiamo a fondo con tutti i vestiti addosso!…”
Immaginatevi un luogo, in cui si siano dati appuntamento varie persone. Alcune hanno studiato tanto, altre un poco meno, altre molto di più anche se professionalmente si percepiscono inferiori a quelle che hanno studiato meno, altre, molto più dotate di tutte, non possono fare parte del gruppo, perché il gruppo non le vuole.
L’accrocco si riunisce ed i membri convenuti iniziano ad esternare desiderata e necessità. Alcuni criticano le esigenze di altri, che, a loro volta, criticano il luogo di ritrovo. C’è chi ha da ridire sull’orario dell’appuntamento, chi desidera usare il treno, qualcuno ha già l’auto in moto (ovviamente parcheggiata in doppia fila), alcuni sono già a cavallo di costosissime biciclette. Tutti criticano e basta, anche senza un ben preciso motivo. Ognuno dice ciò che più conviene a se stesso ed a quelli che sente suoi pari. Chi si pavoneggia per i titoli accademici, chi si sente forte per nascita e per conoscenze, altri si disperano perché la vita trascorre e non hanno potuto attribuire ad essa il significato desiderato. Qualcuno alza la voce, qualcuno ammicca, qualcuno sentenzia che sia tutto da rifare, qualcuno che “quelli sì che erano tempi”, altri lanciano anatemi con chi solo pensa di pronunciare le cose che fanno girare il mondo, ma che la comitiva, così dotta e titolata, ignora nei significati e negli utilizzi. Nessuno, però, si chiede dove si debba andare, per quale motivo ed a beneficio di chi.
È emerso questo sentimento nel gruppo di lavoro della redazione, dopo lo studio dell’ultimo lavoro di Franceso Erbani, dal titolo “Lo stato dell’arte”, per i tipi di Manni Editori. È un saggio che narra di musei, di archivi, di aree archeologiche, di biblioteche, di centri storici e di vicende inerenti le soprintendenze. È un lavoro che cerca di fare il punto sulla situazione della organizzazione del sistema dei beni culturali italiani, descrivendone eventi ed evoluzioni istituzionali e politiche. Racconta di retorica istituzionale e delle misere dotazioni finanziarie e di risorse umane del settore. Si chiede del senso del concetto di bene culturale e di cosa possa rappresentare per un territorio, della fatica, in tutti i sensi, per recuperarlo, custodirlo assicurarlo alla collettività.
Ci preme condividere, però, in apertura di recensione, un passaggio tratto dal prologo del testo: “Questo libro ha l’andatura dell’inchiesta giornalistica, prova a raccontare e a interpretare, seleziona, mette insieme fatti e tenta di analizzarli servendosi dell’aiuto di diversi interlocutori. E perciò non aspira a una qualche forma di ipocrita obiettività“. Siamo, quindi, di fronte ad una persona onesta, ad un giornalista che non cede, almeno stando alle risultanze dei contenuti, alle lusinghe del protagonismo. Ammette, pertanto, l’applicazione di una prospettiva politica, che, proprio in virtù della citata ammissione, rende quanto esposto affidabile, non malizioso né malevolo, ma una istantanea di qualche decennio di politica dei beni culturali italiani. Se poi, come per tante foto accade, qualche personaggio risulta “mosso”, irrequieto se non inquietante, sappiate che non è colpa del fotografo e perdonate, pertanto, all’autore il trasporto umano umilmente denunciato.
Dal punto di vista della tecnica giornalistica, essendo noi ricercatori e dediti alla più profonda fedeltà galileiana, non siamo certo in grado di giudicarla. Ci pare, però, evidente l’impegno e l’accuratezza nella narrazione, puntuale e comprovata con descrizioni attente di fatti e circostanze, che, purtroppo, non fanno certo onore al nostro sistema culturale e museale.
Intendiamoci, non è un testo di scienze museali ed è inutile cercarvi altro che un’ottima esposizione di fatti inerenti l’evoluzione della politica dell’amministrazione dei beni culturali nel nostro Paese degli ultimi decenni. Chi fa il nostro mestiere ritroverà molte cose purtroppo conosciute e la lettura potrebbe procurare travasi di bile e crisi nervose. Riteniamo, invece, possa essere un testo indovinato, a cui dare massima visibilità tra i frequentatori delle cose culturali. Il pubblico, o come va di moda dire ora, i pubblici (sintomatico che tale aspetto linguistico sia stato, in certi lavori, salutato come una conquista scientifica) hanno sovente un’idea del nostro sistema di gestione dei beni culturali, molto lontana dalla realtà. È una percezione che si dibatte tra il “sentito dire” e sentimenti di assoluta ed incondizionata fede in ciò che un sistema, sovente autoreferenziale, propina ai propri cittadini.
Ci permettiamo di consigliare “Lo stato dell’arte” a tutti coloro che vogliano “toccare” con mano i costosissimi piedi di argilla di un gigante, su cui, a sproposito, si dice tutto ed il contrario di tutto. Per molti la cultura potrebbe sostituire le acciaierie, un toccasana per l’economia e per l’occupazione, per altri coloro che lavorano nel settore dei beni culturali vivono di aria e di sentimenti, possono, pertanto, essere sottopagati, precari e privati del diritto di protesta, perché la cultura è qualcosa di dovuto: peccato che pochi ne abbiano una idea precisa, istituzioni comprese. È bene che i cittadini conoscano inefficienze, compromessi, sotterfugi, ma soprattutto sappiano che quel re, di cui sbandieriamo successi e percentuali, per cui ci sentiamo, oltre al calcio, orgogliosi nazionalisti, è nudo o, perlomeno, non troppo vestito e, come ci dicevano a scuola, è portato e potrebbe fare molto di più, per tutti.
Ci pare così strano che tanti soggetti, carichi di titoli accademici, riescano a complicare il nulla fatto da altri con altro nulla. Siamo come giovani scioperati, che avendo ereditato costosissimi beni di famiglia, si atteggiano ad artefici di tali ricchezze, mentre lo scopo di tale gestione dovrebbe essere ben altro. Chi ha detto che un archeologo sappia gestire la comunicazione o che uno storico riesca ad analizzare un bilancio, soprattutto se si ignora cosa sia realmente la cultura ed un museo (siamo onesti: vi sono definizioni museali in circolazione, con cui si potrebbe organizzare una fiera del banale). Se un primario fosse, per ricaduta accademico-divina, un ottimo organizzatore non avremmo problemi nella gestione degli ospedali. Non è solo questione di carenza di personale, aspetto correttamente rilevato nel lavoro dell’Erbani, ma di sapere che un sistema, e non solo una azienda, è un insieme definito e regolato da logiche precise e necessita di tante professionalità in grado di conoscerle e gestirle, che il nostro ordinamento, ancora, ignora. Ci sembra ancora più strano che il nostro sistema, aree di restauro e conservazione a parte, non riesca a partorire nulla di particolarmente fondante le scienze museali, sordo a termini quali didattica, neuroscienze, organizzazione, ricerca scientifica, scopi, obiettivi, sperimentazione, informatica, ergonomia, scienze cognitive, misura delle retroazioni, creatività, rapporto tra pubblico e privato (anche considerato come singolo cittadino, non solo come impresa con cui barattare visibilità con denaro).
A proposito di lessico, il quadro, o meglio, l’istantanea che risulta da “Lo stato dell’arte” è talmente complicato, che la stessa trattazione ne risente, senza imputare all’autore alcuna colpa. È il sistema che è talmente complicato da risultare estremamente ostico da narrare in modo lineare, malgrado il riuscito risultato editoriale.
È un testo da fare adottare anche a livello universitario e da utilizzare nei musei per organizzare quei circoli di qualità che il “Kaizen” degli anni Ottanta predicava in Italia come partecipazione dal basso alla soluzione dei problemi. Purtroppo dal basso, nel settore in esame, al momento non può filtrare nulla.
Se proprio vogliamo trovare qualche non pregio a questo ottimo lavoro, proporremmo all’autore di non abusare o di fare molta attenzione ad utilizzare stereotipi lessicali quali: scienza, bellezza, cultura, azienda. Così rischiamo di aggiungere vuoto al vuoto: “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus“.
© Copyright Infogestione
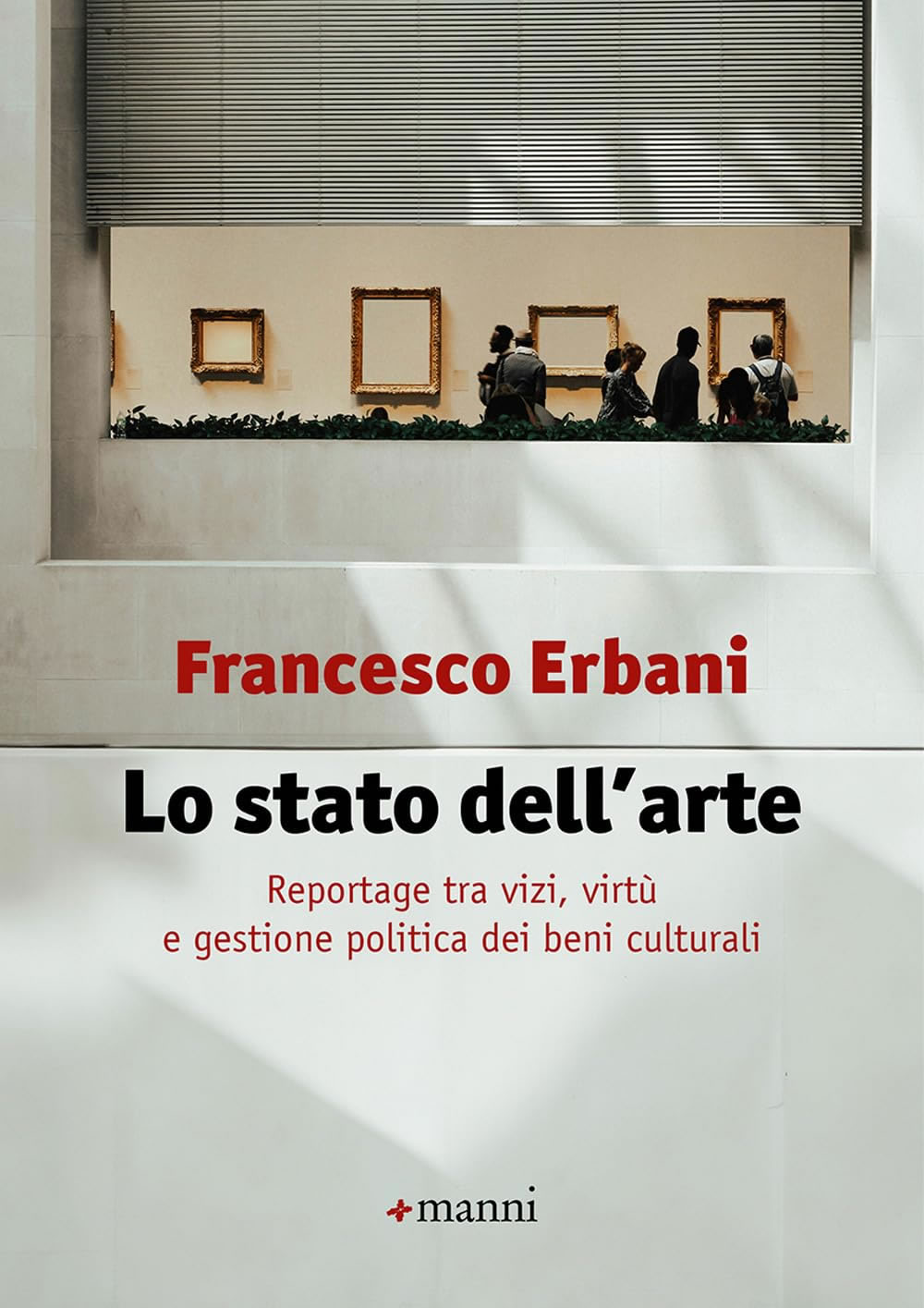
Coordinate di questa pagina, fonti, collegamenti ed approfondimenti.
Titolo: “Lo stato dell’arte”
Sezione: “Libri e musei”
Autore: redazione scientifica di Network Museum
Ospite: –
Codice: INMNET2503061320MAN/A1
Ultimo aggiornamento: 18/03/2025
Pubblicazione in rete: 6° stagione, 18/03/2025
Proprietà intellettuale: INFOGESTIONE s.a.s
Fonte contenuti: INFOGESTIONE – Network Museum
Fonte immagini: – https://www.mannieditori.it
Fonte video e contenuti multimediali: –
Collegamenti per approfondimenti inerenti al tema:
– https://www.mannieditori.it


